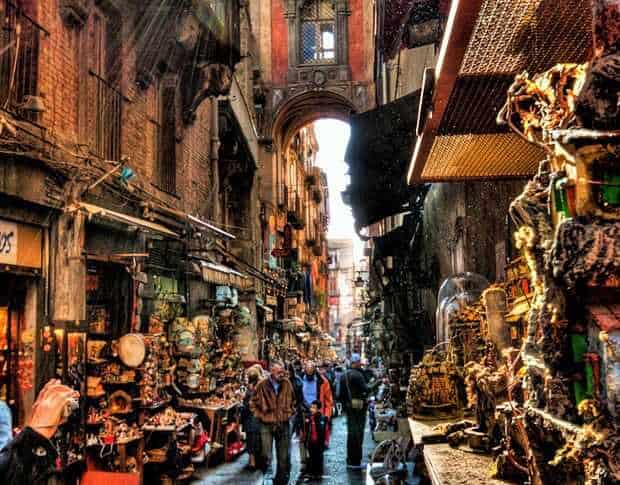“Il Cristo Velato è l’opera più stupefacente che l’arte abbia mai creato.” Con queste parole Antonio Canova, il più grande scultore neoclassico della storia, descriveva la sua emozione di fronte al capolavoro di Giuseppe Sanmartino nella Cappella Sansevero di Napoli.
Un velo di marmo così sottile da far credere all’impossibile, uno scultore geniale e un principe alchimista. Dietro il Cristo Velato di Napoli si nasconde una storia che ha dell’incredibile, fatta di misteri mai svelati e tecniche artistiche che ancora oggi lasciano senza fiato milioni di visitatori.
La Prima Vista di Canova al Cristo Velato
Durante il suo viaggio a Napoli nel 1780, Antonio Canova si fermò nella Cappella Sansevero. Il silenzio calò nella sala quando il celebre scultore, già famoso in tutta Europa, si inginocchiò davanti al Cristo Velato. “Rinuncerei a dieci anni della mia vita pur di aver scolpito questo Cristo,” sussurrò Canova, con le lacrime agli occhi. Un momento storico che segnò per sempre il destino di quest’opera straordinaria.
Le cronache dell’epoca raccontano che Antonio Canova tornò più volte alla Cappella Sansevero, spesso nelle prime ore del mattino, per studiare il Cristo Velato in solitudine. “Ogni volta che lo osservo,” scrisse nei suoi appunti, “scopro nuovi dettagli che mi lasciano senza parole.” La sua ammirazione per l’opera di Sanmartino divenne leggendaria negli ambienti artistici europei.
Il Cristo Velato: Un’Opera che ha Cambiato la Storia dell’Arte
Il Cristo Velato non è solo una scultura: è una sfida all’impossibile. Giuseppe Sanmartino, nel 1753, realizzò qualcosa che nemmeno il grande Canova riteneva possibile. Da un unico blocco di marmo, scolpì non solo il corpo di Cristo, ma anche un velo così sottile da sembrare trasparente. Canova stesso dichiarò che “il velo è così realistico che sembra impossibile sia stato scolpito nel marmo.”

L’Omaggio di Canova
“Ho visto miracoli in marmo,” scrisse Canova nei suoi diari, “ma il Cristo Velato supera ogni immaginazione.” L’ammirazione di Canova per quest’opera era tale che, si dice, tornò più volte a Napoli solo per contemplarla. “In questo velo,” affermava, “c’è tutto il genio della scultura italiana.”
Ciò che più colpì Canova del Cristo Velato fu la perfezione anatomica unita alla trasparenza del velo. “Si vedono le vene pulsare attraverso il marmo,” osservò lo scultore, “è come se Sanmartino avesse dato vita alla pietra.” Il velo, sottile come tessuto vero, lascia intravedere:
- Il volto sofferente di Cristo
- Le ferite della corona di spine
- Il costato trafitto
- La muscolatura perfettamente definita
L’incontro con il Cristo Velato influenzò profondamente lo stile di Canova. Nelle sue opere successive, lo scultore tentò più volte di replicare l’effetto del velo di marmo, senza mai raggiungere, per sua stessa ammissione, la perfezione del Sanmartino.
Come Sanmartino riuscì a creare un velo così sottile da un blocco di marmo? Questo enigma tormentò Canova per anni. “Ho studiato ogni centimetro di quest’opera,” confessò, “ma il suo segreto rimane un mistero.” La leggenda vuole che il principe di Sangro, committente dell’opera, avesse utilizzato un procedimento alchemico, ma Canova stesso smentì questa teoria, attribuendo tutto al genio di Sanmartino.
“Nemmeno le mie opere migliori reggono il confronto con il Cristo Velato,” confessò Canova ai suoi allievi. Una dichiarazione sorprendente da parte di chi aveva scolpito capolavori come “Amore e Psiche” e il “Monumento a Maria Cristina d’Austria”. Il velo di marmo del Cristo Velato rappresentava per lui il vertice assoluto dell’arte scultorea.
L’ossessione di Canova per il Cristo Velato lo portò a studiarne ogni minimo dettaglio. Notò come Sanmartino aveva creato l’effetto della trasparenza variando lo spessore del marmo fino a renderlo quasi impalpabile. “Il velo sembra respirare,” osservò Canova, “come se il marmo si fosse trasformato in tessuto vivo.”
L’ammirazione di Canova per il Cristo Velato influenzò profondamente il movimento neoclassico. “Quest’opera dimostra che la perfezione barocca può fondersi con l’ideale classico,” dichiarò lo scultore. Il suo entusiasmo contribuì a far conoscere il capolavoro di Sanmartino in tutta Europa.

La Testimonianza più Toccante
Tra tutte le testimonianze di Canova sul Cristo Velato, la più emozionante rimane quella scritta dopo la sua ultima visita: “Ho visto la perfezione nel marmo. Ho visto un velo che sembra di seta, un corpo che sembra respirare. Ho visto l’impossibile diventare reale sotto lo scalpello di Sanmartino.”
L’Eredità di Due Geni
Oggi, il Cristo Velato continua a stupire come ai tempi di Canova. Nel 2023, oltre mezzo milione di visitatori hanno ammirato l’opera che fece inginocchiare il più grande scultore neoclassico. “Chi non ha visto il Cristo Velato,” diceva Canova, “non può comprendere fino a che punto possa spingersi l’arte della scultura.”
La passione di Canova per il Cristo Velato accese un vivace dibattito nel mondo dell’arte. Molti scultori dell’epoca si recarono a Napoli solo per verificare se le parole di Canova fossero esagerate. Nessuno rimase deluso. “Canova aveva ragione,” scrisse lo scultore Bertel Thorvaldsen, “è un’opera che va oltre i confini dell’arte.”
L’ammirazione di Canova ha contribuito a costruire il mito del Cristo Velato. Ancora oggi, gli studenti delle accademie d’arte studiano come Sanmartino sia riuscito a ottenere effetti che nemmeno il grande Canova riuscì a replicare. “Il velo del Cristo,” scrisse nelle sue memorie, “rimarrà per sempre il più grande miracolo della scultura.”
Il Cristo Velato Oggi
A distanza di secoli, le parole di Canova continuano a risuonare nella Cappella Sansevero. Il Cristo Velato rimane un’opera che sfida la comprensione, proprio come quando il più grande scultore neoclassico si inginocchiò davanti ad essa, ammettendo che la sua arte non poteva eguagliare quella di Sanmartino.
Consigli per la Visita
- Prenotate in anticipo nei periodi di alta stagione
- Visitate la Cappella nelle prime ore del mattino per una migliore esperienza
- Non dimenticate di scendere nei sotterranei per vedere le Macchine Anatomiche
- L’audioguida (3,50€) offre approfondimenti imperdibili sulla storia dell’opera
Indirizzo, orari e Biglietti
- Via de Sanctis Francesco, 19/21, 80134 Napoli. Tel./fax: +39 081 5518470
- Aperto tutti i giorni: 09:00 – 19:00.
- Ultimo ingresso consentito 30 min. prima della chiusura.
- Chiuso il martedì
- Biglietto ordinario: € 7,00,
- Ragazzi da 10 a 25 anni € 5,00.
- Artecard: € 5,00.
- Soci FAI: € 5,00.
- Bambini fino a 9 anni: gratis.
- Scuole*: € 3,00 (tariffa valida solo nei giorni feriali).
- Audioguida: € 3,50